



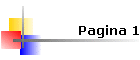

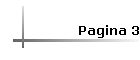
|
Sulmona |
.
 "Sulmona è la
mia patria" cantò Ovidio consegnando la memoria della città alla storia Ci avviamo
a chiudere il secolo e con esso liquideremo anche il Millennio, il secondo dell'era
cristiana, ma forse il terzo per la vetusta Sulmona che, come narrarono i fantasiosi
scrittori del passato, con forte anticipo sulla nascita di Roma era stata fondata da
Solimo, fortunosamente scampato assieme ad Enea e ai suoi compagni alla distruzione di
Troia. Quei protosulmonesi, che in realtà non erano oriundi della lontana Frigia ma solo
italici peligni, rifuggendo dalle paludi acquitrinose del fondovalle avevano fissato
stabile dimora in stazzi e capanne sui rilievi del Monte Mitra, difendendoli con possenti
muraglie innalzate con grossi blocchi calcarei sbozzati dalle callose mani di tagliapietre
improvvisati. Ed erano cresciuti in numero e in possanza pascolando le greggi e coltivando
la terra, avevano barattato lane e pelli, avevano imparato a plasmare l'argilla, a
forgiare il metallo: così, giorno dopo giorno, per secoli. Poi erano scesi dai monti per
costruire nuovi abitacoli sul piccolo dosso incuneato tra i fiumi, circuendo anche quei
pochi iugeri di terra con mura sicure, che videro passare le truppe di Annibale, li
protessero quando levarono gli scudi contro Roma, si aprirono alle coorti cesariane di
Marcantonio. Poi la pax augustea, la nuova lingua, le nuove divinità; la piccola Sulmo si
fece città, i luoghi sacri divennero monumenti, i tuguri dimore sontuose. Sulmo mihi
patria est, cantò in quel tempo non senza un pizzico di orgoglio il sommo Ovidio,
consegnando la sua gente alla storia del primo millennio. Altri dieci secoli, una nuova
era che vedeva sgretolarsi il mondo classico e l'affermarsi del Cristianesimo. Sulmona,
come ora si chiamava quello che era stato uno dei tre municipia della terra dei Peligni,
reggeva in qualche modo all'urto delle invasioni barbariche e, protetta dal guscio delle
vecchie mura, varcava la soglia dell'anno Mille conservando almeno in parte l'essenza
dell'antica dignità urbana: una fortuna che non era toccata a Corfinio che della
decantata metropoli italica aveva perso perfino il nome. E quando le mutate condizioni
socio politiche restituirono le aree urbanizzate alla loro piena funzione di poli centrali
della vita comunitaria, imponenti flussi migratori muovendo dalla campagna e dai villaggi
vicini e lontani rivitalizzarono anche il vetusto abitato sulmonese, tanto che il vescovo
valvense prese a soggiornarvi con crescente frequenza, fino ad abbandonare per sempre la
turrita residenza corfiniese, bella e carica di storia ma isolata nella sua solitudine,
ormai quasi cattedrale nel deserto. Poi la splendida ma troppo breve parentesi sveva: il
giustizierato, le fiere annuali, la cattedra di Diritto Canonico concorsero con
l'irrobustito potenziale demico allo sviluppo urbanistico della città: gli edifici
pubblici e privati accresciuti e rinnovati, l'arrivo dei grandi ordini dei Mendicanti e di
quel Pietro Angelerio da Isernia che darà vita e vigore alla montagna sacra dei Peligni,
i nuovi borghi, la grande piazza del mercato con le botteghe di Porta Salvatoris a far da
volano alla dinamica mercantile, ne faranno in breve la capitale indiscussa della giovane
regione sorta ai confini del regno. Monumento emblematico di quel tempo felice,
l'acquedotto medievale; Sulmontinorum laus, come con giustificata enfasi si scrisse sulla
pietra posta a ricordo del suo completamento in quel lontano 1256: una condotta
sopraelevata su ventuno possenti arcate ogivali che si rincorrono per oltre cento metri,
impropriamente riferita a re Manfredi, ma che era già compiuta ancor prima che il figlio
naturale di Federico salisse al trono. E ora che la critica ha accreditato di maggiore
antichità il frammento di affresco del Museo Civico recuperato all'inizio del secolo da
un edificio in ristrutturazione - che vorremmo tanto poter identificare con una delle
domus curie, que sunt apud Sulmone delle fonti storiche - la città vanta anche un'altra
reliquia del tempo degli Svevi, meno appariscente, forse, ma altrettanto suggestiva.
Difatti, con un po' di fantasia condita da un pizzico di amore per il campanile, che nella
giusta dose non guasta mai, in quell'enigmatico personaggio di nobile lignaggio, per quasi
un secolo creduto re Ladislao di Durazzo, potrebbe ravvedersi il grande imperatore o, se
volete, quel giovane che "biondo era, e bello e di gentile aspetto" di dantesca
memoria che fu Manfredi. Ma venne la triste giornata dei Campi Palentini e - per dirla con
l'Aleardi - "come dilegua una ardente stella, mutò zona lo svevo astro e
disparve"; con la testa di Corradino mozzata sulla piazza del mercato di Napoli
caddero anche le fortune dei Sulmonesi. Lutti, esili e confische colpirono i partigiani -
ed erano tantissimi - del giovane rampollo degli Hohenstaufen, mentre l'avversa politica
angioina privava la città di molti dei suoi privilegi. Riuscirà, però, a completare in
qualche modo il grande progetto di età federiciana e avrà la sua grande piazza del
mercato, allargherà la cinta muraria a contenere il complesso cattedrale-episcopio e i
nuovi borghi sorti alla periferia del primitivo nucleo, trasformerà in senso monumentale
chiese e palazzi. E nel mentre fioriranno botteghe artigiane e attivissimi commerci, che
convoglieranno lana, seta e zafferano verso i grandi empori mercantili della Penisola,
uomini di cultura di valore assoluto, maestranze indigene e forestiere, magistri esperti
nell'arte dell'oro e dell'argento daranno lustro e spessore all'immagine della città. "Sulmona è la
mia patria" cantò Ovidio consegnando la memoria della città alla storia Ci avviamo
a chiudere il secolo e con esso liquideremo anche il Millennio, il secondo dell'era
cristiana, ma forse il terzo per la vetusta Sulmona che, come narrarono i fantasiosi
scrittori del passato, con forte anticipo sulla nascita di Roma era stata fondata da
Solimo, fortunosamente scampato assieme ad Enea e ai suoi compagni alla distruzione di
Troia. Quei protosulmonesi, che in realtà non erano oriundi della lontana Frigia ma solo
italici peligni, rifuggendo dalle paludi acquitrinose del fondovalle avevano fissato
stabile dimora in stazzi e capanne sui rilievi del Monte Mitra, difendendoli con possenti
muraglie innalzate con grossi blocchi calcarei sbozzati dalle callose mani di tagliapietre
improvvisati. Ed erano cresciuti in numero e in possanza pascolando le greggi e coltivando
la terra, avevano barattato lane e pelli, avevano imparato a plasmare l'argilla, a
forgiare il metallo: così, giorno dopo giorno, per secoli. Poi erano scesi dai monti per
costruire nuovi abitacoli sul piccolo dosso incuneato tra i fiumi, circuendo anche quei
pochi iugeri di terra con mura sicure, che videro passare le truppe di Annibale, li
protessero quando levarono gli scudi contro Roma, si aprirono alle coorti cesariane di
Marcantonio. Poi la pax augustea, la nuova lingua, le nuove divinità; la piccola Sulmo si
fece città, i luoghi sacri divennero monumenti, i tuguri dimore sontuose. Sulmo mihi
patria est, cantò in quel tempo non senza un pizzico di orgoglio il sommo Ovidio,
consegnando la sua gente alla storia del primo millennio. Altri dieci secoli, una nuova
era che vedeva sgretolarsi il mondo classico e l'affermarsi del Cristianesimo. Sulmona,
come ora si chiamava quello che era stato uno dei tre municipia della terra dei Peligni,
reggeva in qualche modo all'urto delle invasioni barbariche e, protetta dal guscio delle
vecchie mura, varcava la soglia dell'anno Mille conservando almeno in parte l'essenza
dell'antica dignità urbana: una fortuna che non era toccata a Corfinio che della
decantata metropoli italica aveva perso perfino il nome. E quando le mutate condizioni
socio politiche restituirono le aree urbanizzate alla loro piena funzione di poli centrali
della vita comunitaria, imponenti flussi migratori muovendo dalla campagna e dai villaggi
vicini e lontani rivitalizzarono anche il vetusto abitato sulmonese, tanto che il vescovo
valvense prese a soggiornarvi con crescente frequenza, fino ad abbandonare per sempre la
turrita residenza corfiniese, bella e carica di storia ma isolata nella sua solitudine,
ormai quasi cattedrale nel deserto. Poi la splendida ma troppo breve parentesi sveva: il
giustizierato, le fiere annuali, la cattedra di Diritto Canonico concorsero con
l'irrobustito potenziale demico allo sviluppo urbanistico della città: gli edifici
pubblici e privati accresciuti e rinnovati, l'arrivo dei grandi ordini dei Mendicanti e di
quel Pietro Angelerio da Isernia che darà vita e vigore alla montagna sacra dei Peligni,
i nuovi borghi, la grande piazza del mercato con le botteghe di Porta Salvatoris a far da
volano alla dinamica mercantile, ne faranno in breve la capitale indiscussa della giovane
regione sorta ai confini del regno. Monumento emblematico di quel tempo felice,
l'acquedotto medievale; Sulmontinorum laus, come con giustificata enfasi si scrisse sulla
pietra posta a ricordo del suo completamento in quel lontano 1256: una condotta
sopraelevata su ventuno possenti arcate ogivali che si rincorrono per oltre cento metri,
impropriamente riferita a re Manfredi, ma che era già compiuta ancor prima che il figlio
naturale di Federico salisse al trono. E ora che la critica ha accreditato di maggiore
antichità il frammento di affresco del Museo Civico recuperato all'inizio del secolo da
un edificio in ristrutturazione - che vorremmo tanto poter identificare con una delle
domus curie, que sunt apud Sulmone delle fonti storiche - la città vanta anche un'altra
reliquia del tempo degli Svevi, meno appariscente, forse, ma altrettanto suggestiva.
Difatti, con un po' di fantasia condita da un pizzico di amore per il campanile, che nella
giusta dose non guasta mai, in quell'enigmatico personaggio di nobile lignaggio, per quasi
un secolo creduto re Ladislao di Durazzo, potrebbe ravvedersi il grande imperatore o, se
volete, quel giovane che "biondo era, e bello e di gentile aspetto" di dantesca
memoria che fu Manfredi. Ma venne la triste giornata dei Campi Palentini e - per dirla con
l'Aleardi - "come dilegua una ardente stella, mutò zona lo svevo astro e
disparve"; con la testa di Corradino mozzata sulla piazza del mercato di Napoli
caddero anche le fortune dei Sulmonesi. Lutti, esili e confische colpirono i partigiani -
ed erano tantissimi - del giovane rampollo degli Hohenstaufen, mentre l'avversa politica
angioina privava la città di molti dei suoi privilegi. Riuscirà, però, a completare in
qualche modo il grande progetto di età federiciana e avrà la sua grande piazza del
mercato, allargherà la cinta muraria a contenere il complesso cattedrale-episcopio e i
nuovi borghi sorti alla periferia del primitivo nucleo, trasformerà in senso monumentale
chiese e palazzi. E nel mentre fioriranno botteghe artigiane e attivissimi commerci, che
convoglieranno lana, seta e zafferano verso i grandi empori mercantili della Penisola,
uomini di cultura di valore assoluto, maestranze indigene e forestiere, magistri esperti
nell'arte dell'oro e dell'argento daranno lustro e spessore all'immagine della città.
SUCCESSIVA>> 1
di 3 |
|
|
|